
Quando la Russia ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022, ero in Italia ad assistere mio padre malato. Erano gli ultimi mesi di vita di un ultraottantenne che, per più della metà della sua esistenza, era stato militare e da militare aveva vissuto tutta la guerra fredda. Mio padre era figlio della seconda guerra mondiale e, a sua volta, figlio di un ufficiale che in Ucraina c'era stato: come invasore, tra il 1941 e il 1943, con l'armata italiana che Mussolini aveva inviato a fiancheggiare Hitler nella sua operazione Barbarossa. Uno dei tanti che ci andarono, uno dei pochi che tornarono vivi.
Quando mio padre vide in TV le immagini di guerra e le mappe dei luoghi dell'invasione, mi raccontò di nuovo la storia di suo padre: una storia in verità succinta, piena di non detti, la storia di un ufficiale che a Dnipropetrovsk si occupò di gestire un campo di prigionia per i soldati sovietici catturati durante la prima avanzata, vincente e criminale, delle armate dell'Asse.
Mio padre vedeva e sentiva male, ma i nomi dei luoghi, anche se cambiati nel frattempo, se li ricordava. E di suo padre ricordava solo che parlava malissimo dei tedeschi: perché a Dnipropetrovsk aveva probabilmente visto quello che fecero alla popolazione locale, sia quella ucraina che quella ebraica, quasi completamente sterminata.
In quelle settimane pensai: in chissà quante famiglie italiane adesso i più anziani stanno tirando fuori tragici ricordi di padri, nonni e bisnonni.
Mio padre morì a dicembre del 2022: fece in tempo a vedere la resistenza degli ucraini, i territori riconquistati e le atrocità che si rivelarono al mondo in quei primi mesi di occupazione. Non fece in tempo a vedere, invece, il progressivo calare dell'attenzione, quasi indifferenza, che gli italiani mostrarono verso l'Ucraina. Perché, nonostante la mia speranza, invece che dialoghi difficili in famiglia calò quasi ovunque il silenzio. Gli italiani non si sentivano coinvolti da quelle vicende e spesso ignoravano il passato delle proprie famiglie. O, semplicemente, non gli importava.
Ma una delle voci migliori della letteratura italiana ha poi rotto quel silenzio: con una lunga lettera al padre, un racconto biografico e storico, fatto per ristabilire la verità del passato e del presente — e ricordare agli italiani la loro responsabilità, sul passato e sul presente.
L'autrice è Francesca Melandri, il libro, uscito nel 2024 in contemporanea in Italia e Germania, è "Piedi Freddi". E di questo libro oggi vi parlo.
«Eccole, papà, le donne di cui hai parlato così spesso, sempre di più con il passare degli anni. Le ho viste, le tue donne, nella prima settimana di guerra. In un video di YouTube, figurati, YouTube non lo conoscevi nemmeno quando eri in vita. Indossavano felpe con cappuccio e stivali di feltro, questi esseri mitici senza i quali saresti solo un nome in un ossario - o un nome e nient'altro - senza i quali io non esisterei. Era il video con quel soldato russo, magro, pallido, terribilmente giovane. Le sue guance pallide.»
Così inizia la lunga lettera che Melandri scrive al padre morto: guardando un video in cui donne ucraine soccorrono, sfamano e consentono a un soldato russo di chiamare a casa con il loro cellulare, mentre altrove altri soldati russi stupravano e uccidevano donne, bambini e anziani ucraini. Ucraine furono anche le donne che soccorsero suo padre durante la rovinosa ritirata, dandogli cibo e vestiti. Erano le stesse donne contro cui meno di due anni prima i soldati tedeschi e i loro alleati si erano accaniti nell'avanzata di Russia.
Solo che, come Melandri ricorda come un mantra dall'inizio alla fine del racconto-lettera, quella che gli italiani chiamavano "Campagna di Russia", in verità era Ucraina.
Come abbiamo potuto ignorarlo per tanto tempo? Come abbiamo potuto ignorare, anche, che quella spedizione militare in Russia, che in verità era Ucraina, era una guerra coloniale, si chiede Melandri mentre ripercorre i ricordi del padre e al padre racconta quello che oggi accade in quegli stessi luoghi. E come possiamo oggi ignorare che coloniale è anche la guerra che la Russia fa contro l'Ucraina? Come possiamo essere così esitanti nel dare il giusto nome alle cose, e nel prendere la parte giusta in una guerra che non solo non è breve, ma potrebbe presto bussare alla nostra porta?
Questa esitazione, nell'espressione idiomatica inglese, si chiama "avere i piedi freddi" ("to get cold feet"), riferendosi alla paura di affrontare qualcosa di necessario. Il gelo dei piedi è anche uno dei ricordi chiave del racconto, che ritorna lungo le pagine — comune ai tanti soldati che, privi di attrezzatura, dovettero ritirarsi con marce forzate lungo le steppe che chiamavamo russe ma erano in realtà ucraine, a partire dal dicembre 1942.
Questo è il doppio significato del titolo del libro: si riferisce letteralmente ai piedi congelati dei soldati italiani durante la guerra del 1941-42 in Ucraina, e metaforicamente all'esitazione dell'Europa occidentale di fronte a Putin.
Francesca Melandri, nata nel 1964, è stata a lungo sceneggiatrice prima di dedicarsi alla scrittura: nei suoi libri — siano essi romanzi o, come in questo caso, un ibrido tra biografia e pamphlet — il testo si trasforma in immagini vivide nella mente del lettore.
Le opere di Melandri non cercano rifugio in un passato immaginario: dalla storia coloniale alle tensioni etniche dell'Italia, l'autrice porta alla luce le verità taciute e la storia che preferiamo dimenticare. Questa sensibilità storica spiega probabilmente il suo grande successo in Germania, persino maggiore di quello ottenuto in patria. In «Piedi freddi», attraverso il dialogo con il padre — interrogandolo e interrogandosi — Melandri ci spinge a riflettere sul vero significato della pace e sul peso dei principi che tanto facilmente proclamiamo, senza comprendere che per difenderli, prima o poi, occorre pagare un prezzo.
«“Mai più guerra!” abbiamo detto per ottant’anni. Pensavamo che dirlo fosse un impegno specifico, concreto. Che significasse: “Non tollereremo mai più aggressioni militari, né guerre genocidarie né invasioni di eserciti, le combatteremo con ogni mezzo, difenderemo il diritto internazionale basato sulla inviolabilità dei confini senza il quale non può esistere la democrazia.” In realtà stavamo solo dicendo: “Se arriva la guerra non ce la vogliamo trovare davanti. Che sia solo altrove, grazie. Che la guerra non ci riguardi, se non per un vago e compiaciuto afflato di immensa compassione per sofferenze lontane.” Immensa, appunto, solo perché ben lontane.»
Ma ora?
«La guerra è qui. La guerra ha raggiunto il nostro continente. E per quanto desideriamo che svanisca come per magia - no, non svanisce. La nostra onnipotenza è stata svuotata. Siamo fastidiosamente chiamati a mettere in pratica i principi che per decenni abbiamo sbandierato. Anzi, peggio: per difendere quei principi siamo chiamati addirittura a pagare un prezzo!»
La lettera-racconto di Melandri non è cronologica, ma organizzata per temi, spesso incentrati su domande irrisolte. Melandri, consapevole di scrivere per un pubblico poco familiare con questi eventi, riesce a ricostruire, senza eccessi di dettagli storici, quella campagna coloniale degli italiani in quella che chiamavano Russia ma era in realtà Ucraina.
Porta in primo piano ciò che è stato taciuto e mai ammesso: per esempio, che proprio come i soldati russi nel 2022-2023, anche gli italiani del 1941-1942 saccheggiarono sistematicamente le terre nere ucraine, trasportando verso casa, su treni e carri, tutto ciò che poteva essere utile all'Italia - un Paese già allo stremo delle forze ma che ancora inseguiva i tedeschi in guerre che non poteva vincere.
«Dalla metà del 1942, con il tuo arrivo, operava nel territorio occupato dall'ARMIR una commissione composta da dirigenti della Pirelli, della Società dell'Agroindustria, del Ministero dell'Agricoltura e di diverse università. Il compito di questa commissione era di organizzare la produzione industriale della gomma. Nelle terre nere c'era così tanta guttaperca - produttiva come tutto il resto - che l'Italia avrebbe potuto competere con gli Stati Uniti nella produzione di pneumatici! […] Per il trasporto di tutti questi tesori furono predisposti interi convogli ferroviari, contrassegnati con la scritta PROPRIETÀ DEL REGIO ESERCITO e dotati di diritto di precedenza.»
[…]
«Poi c'erano naturalmente i generi alimentari, la ricchezza quasi infinita del granaio dell'Eurasia. La legislazione fascista prevedeva che almeno un terzo del cibo prodotto nei territori occupati andasse ai civili; ma l'ordine dei comandi era di lasciare alla popolazione "solo il minimo necessario per la sopravvivenza".»
[…]
«E poi c'erano farina, miele, burro e soprattutto grano. Tanto, tantissimo grano. Un sottufficiale riuscì per mesi a spedire a casa ogni giorno diversi pacchi da dieci chili di grano, finché i suoi superiori non ritennero che stesse un po' esagerando. E chissà se anche tu non abbia spedito qualche pacco di questo oro biondo dall'Ucraina a tua madre Bianca.»
Tutta questa parte della storia — l'occupazione, lo sfruttamento, le esecuzioni sommarie — è scomparsa dal racconto popolare italiano e anche dai libri di storia.
L'unica parte della storia che viene raccontata in Italia è quella della ritirata: una storia tragica nelle dimensioni e nella sofferenza dell'ARMIR (Armata Italiana in Russia), che contava circa 230.000 uomini, di cui circa 95.000 non fecero ritorno.
Tra i prigionieri catturati dall'Armata Rossa, circa 70.000 furono inviati nei campi di prigionia e solo poco più di 10.000 riuscirono a tornare in Italia dopo la guerra. Una storia raccontata come epica, in effetti piena di sacrificio e di amicizia — ma forse anche d'altro e di peggio, non lo sapremo mai.
E non lo sapremo perché nel frattempo ha prevalso la narrazione vittimistica: quindi nessuno parla di Marcia di occupazione in Russia, ma di Ritirata dalla Russia, che in verità era Ucraina, come se i più di duecentomila soldati italiani ci fossero stati catapultati lì come in un'astronave, non a bordo di carri armati, mezzi blindati e motocicli da guerra.
Il culmine di tutto questo, racconta Melandri mentre parla al padre morto e a noi vivi, avviene proprio nel 2022, l'anno dell'invasione russa su larga scala: a maggio 2022 il Parlamento italiano approva una legge che stabilisce il 26 gennaio come data commemorativa della ritirata dei soldati italiani dal fronte russo, ovvero dall'Ucraina. La data scelta corrisponde alla battaglia di Nikolajewka, e il testo del primo articolo, che Melandri riporta nel suo libro, recita così:
«Articolo 1 La Repubblica riconosce il giorno 26 gennaio di ciascun anno quale Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini, al fine di conservare la memoria dell’eroismo, del valore e dell’abnegazione degli Alpini e di promuovere i valori della difesa della sovranità e dell’indipendenza nazionale, della solidarietà e del volontariato.»
Peccato, osserva Melandri, che quella guerra non fosse in nome della sovranità e dell'indipendenza dell'Italia, ma fosse una guerra di occupazione. Di quella che allora veniva chiamata Russia, ma che in realtà è Ucraina. E la data?
«Il 26 gennaio è proprio il giorno precedente alla Giornata Internazionale della Memoria delle vittime dell'Olocausto. Come se fosse del tutto irrilevante che la macchina dello sterminio sia stata perfezionata nella stessa guerra in cui i soldati italiani - inclusi gli Alpini, incluso tu, papà - erano alleati dei nazisti.»
«Il 27 gennaio 1945, quando l'Armata Rossa liberò Auschwitz, tu eri a Torino, a lavorare come giornalista nella redazione di un giornale che pubblicava quotidianamente i comunicati ufficiali di Joseph Goebbels. E ora, papà, ecco la domanda più indicibile, quella che non ho mai potuto farti: quando hai visto per la prima volta le immagini delle fabbriche della morte, cosa hai pensato?»
Più il racconto avanza, intrecciando la cronaca presente e i ricordi del passato, più sono le domande, spesso scomode, che Francesca Melandri si pone pensando alla biografia del padre.
Come ha potuto, per esempio, firmare ancora un editoriale che indicava il fascismo come l'unica via possibile per l'Italia, pochi giorni prima che Torino venisse liberata dai partigiani? Per quello scritto Franco Melandri - suo padre - avrebbe potuto essere linciato, nel clima di vendetta delle settimane che seguirono nel 1945. Fu invece salvato da un capo partigiano, Massimo Rendina, che era stato suo compagno di ritirata dalla Russia, e che si ricordava sia dell'aiuto reciproco che del fatto che una volta tornati in Italia, Melandri padre non lo avesse tradito.
Qualche anno fa Melandri incontrò il partigiano Massimo Rendina, anche per capire meglio la storia che aveva in comune con suo padre, e gli chiese: "Che cos'è il fascismo?" "Il fascismo non è un fenomeno politico", le rispose. "Il fascismo è un'attitudine mentale". Rendina le confermò ancora che il padre era fascista, ma dignitoso.
Questa è anche la verità: c'erano anche fascisti "dignitosi". Ma questo non ci esenta dalla necessità di fare i conti con questo passato.
Melandri, in verità, non si accontenta del sigillo di dignità di Rendina: ha paura di scoprire che suo padre potrebbe aver partecipato a eccidi e crimini di guerra. Per questo, con in mano il vecchio libro sulla ritirata che il padre Franco aveva scritto, va alla ricerca di fatti e luoghi. Non lo fa per cattiva fede, ma per rimuovere le ombre: tutta quella conoscenza accumulata confluisce in questo libro, ottimamente documentato.
Il racconto procede personale ed emozionale, ma dentro c'è la Storia: i luoghi e le date dei massacri, anche quelli perpetrati dagli italiani — spesso sono gli stessi luoghi delle torture e delle violenze sui civili fatte dai russi. A ognuno, poi, il dovere di approfondirla, se vuole.
Tra storia dell'Italia del dopoguerra, cronicamente malata di amnesia, e cronaca del presente, Melandri però si chiede anche perché non solo quella guerra non venne davvero elaborata, ma soprattutto il rapporto con i totalitarismi.
In particolare, come è possibile che così tanti italiani siano così compiacenti con la Russia di Putin e invece dimostrino tanta indifferenza per l'Ucraina di Zelenskyj?
Melandri torna indietro nei suoi ricordi personali per trovare questa risposta: una studentessa di liceo negli anni in cui molti professori erano fieri marxisti, e in cui un terzo del Paese votava per un partito comunista che poco o nulla aveva a che fare con il realismo socialista, ma era tuttavia devoto a un'idealizzazione di quel regime. Melandri rivela di aver conosciuto tardi la parola Holodomor, come tutti noi qui a ovest, d'altronde.
Ricorda anzi il modo asciutto con cui un'insegnante di storia e filosofia, comunista convinta, ricordasse la "liquidazione dei Kulaki" come un momento fondamentale della grande riforma agraria comunista sovietica. Quello che quell'insegnante italiana non ricordava è che per essere definiti Kulaki, e quindi liquidati, deportati o fatti morire di fame, bastasse possedere un paio di mucche e un minuscolo appezzamento di terra.
Con maestria, Melandri trova il modo di usare il suo racconto-lettera anche per insegnarci qualcosa di più sulla nostra e sulla storia dell'Ucraina, e anche sul nostro comunismo e sulle tracce tossiche che ha lasciato nella sensibilità di oggi. Per esempio, quell'idea che l'imperialismo sia solo quello a stelle e strisce, mentre non quello dell'Unione Sovietica e di Putin.
Ma una certa benevolenza verso la Russia ha anche origini culturali: a casa Melandri, come a casa mia, la grande letteratura russa riempiva gli scaffali e godeva dello stesso prestigio dei grandi autori occidentali.
Nessuno sapeva dell'esistenza di una grande letteratura ucraina. Nessuno sapeva che Gogol fosse ucraino, sebbene socializzato nell'impero russo e inevitabilmente destinato a scrivere in russo. I nomi della grande letteratura ucraina sono diventati popolari solo dopo, quando la Russia ha scatenato, con le sue invasioni, una diaspora culturale e una fioritura che Putin non aveva certo previsto, così cieco di fronte all'esistenza dell'Ucraina e della sua cultura:
«Non avevo mai sentito parlare di Taras Ševčenko, Lesja Ukraïnka o Ivan Franko. Non avevo mai saputo che la fine della censura zarista sulle pubblicazioni in lingua ucraina dopo la Rivoluzione d'Ottobre aveva portato a una vera fioritura delle opere di scrittori e intellettuali ucraini; e allo stesso modo ignoravo che Stalin negli anni Trenta aveva poi imposto il russo come dogma sovietico e fatto uccidere quasi tutta l'intellighenzia ucraina: centinaia di intellettuali, scrittori, poeti, editori, uomini e donne. L'estrema creatività artistica di quegli anni e la sua totale distruzione passarono alla storia con il nome di "Rinascimento fucilato" - e non ne avevo mai sentito parlare. Ne lessi per la prima volta il 7 marzo 2022.»
In Italia, racconta poi Francesca Melandri, persino il mondo della cultura alta continua a non percepire la differenza fondamentale tra letteratura russa e letteratura ucraina, anche oggi. Nel suo dialogo immaginario con il padre, Melandri si sofferma su Wiktorija Amelina:
«Per questo devo raccontarti di Viktorija Amelina, papà. So che non avrei bisogno di spiegarti che a volte la morte di una persona lontana ci sembra più insopportabile di quella di un vicino - perché ci tocca più profondamente.»
Victoria Amelina, come Melandri, era scrittrice e cosmopolita. Ma a seguito dell'occupazione russa di Donetsk e Luhansk decide di diventare anche altro: decide di documentare i crimini di guerra russi. Lo fa non per rabbia, ma per spirito di giustizia, perché in un tempo futuro la sola pace possibile è una pace giusta.
Quello che, osserva Melandri, troppi pacifisti in Italia dimenticano, quando recitano solo la prima parte dell'articolo della costituzione italiana che dice: "L'Italia ripudia la guerra".
E omettono il resto: che l'Italia riconosce l'autodeterminazione dei popoli e la necessità della giustizia fra i popoli come condizione della pace. Il primo luglio 2023 Victoria Amelina viene uccisa da un drone russo mentre è a cena in pizzeria.
Sei giorni dopo, alla cerimonia di premiazione del più importante premio letterario italiano, il Premio Strega, il presidente della Fondazione, su input del suo ufficio stampa, decide di rendere omaggio alla scrittrice e dichiara quanto sia importante, in una serata così significativa per la letteratura del nostro paese, ricordare la tragica morte di Wiktorija Amelina... la nota scrittrice russa (sic).
«La scrittrice russa. Russa, papà. Ha detto davvero russa.»
Ma nessuno, pensa anche Melandri, si è alzato in quel nobile giardino romano, tra scrittori, giornalisti, editori e gente dei media, per dire l'unica cosa che si sarebbe dovuta dire di fronte a tanto oltraggio:
«No, Wiktorija Amelina era una scrittrice ucraina, russo era solo il missile che l'ha uccisa.»

Melandri è arrabbiata, ma non scrive in modo arrabbiato: quello che trasmette, dalla prima all'ultima pagina, è un misto di stupore e sgomento. Anche di fronte a coloro che, quando annuncia di aver cominciato a lavorare a un libro su suo padre e sull'Ucraina, le dicono:
«Smettila, Francesca, basta con questa maledetta Ucraina!»
Solo il dialogo immaginato con il padre riesce a superare questo sgomento, nella certezza che un uomo perbene come lui, che in Ucraina c'era stato e che della sua guerra aveva scritto, di fronte a Wiktorija Amelina si sarebbe inchinato:
«E so, papà, che anche tu ti saresti inchinato davanti alla morte di Viktorija Amelina, davanti alla madre, poetessa, scrittrice e testimone della guerra.»
Le ultime pagine di "Piedi Freddi" trasformano lo sgomento in pamphlet: contro l'italianissima strategia di sopravvivenza che consiste nel dimenticare o nel trasformare la tragedia in farsa — quella stra tegia che dopo la seconda guerra mondiale ha permesso di riscrivere la storia come se l'Italia non l'avesse persa. E, soprattutto, contro la strategia dell'indifferenza e del “tanto son tutti uguali”: anche di fronte alla valanga di immagini terribili che arrivano dall'Ucraina — immagini che Melandri decide di raccontare ma senza i dettagli peggiori, e confida al padre che, se fosse vivo, non gliele farebbe vedere:
«Se tu fossi qui ora, papà, non ti mostrerei certi video. Per esempio, i video in cui i soldati russi filmano con i loro telefoni quello che fanno ai prigionieri ucraini, e ancora meno quelli delle esecuzioni di massa. Non ti leggerei la traduzione della telefonata - e non la trascriverò nemmeno qui - in cui un soldato russo racconta a sua madre cosa ha fatto a un prigioniero , finché la madre non riattacca perché deve andare a fare la spesa. Se fossi ancora vivo, non ti parlerei dei prigionieri ucraini...»
Eppure, nonostante quei video e quei racconti, molte delle menti brillanti italiane - commentatori, intellettuali, giornalisti - non sono riuscite a pronunciare una sola parola di empatia. E, sottolinea Melandri, anche le conversazioni private si sono fatte scarne.
Tutti i livelli di questa narrazione - i ricordi della guerra del padre, i ricordi personali della figlia, le immagini della guerra di oggi, l'urgenza di far capire che l'Ucraina ci riguarda tutti - convergono in un appello ad assumersi la responsabilità - non la colpa - della propria storia: per gli italiani, la responsabilità di essere stato un Paese dalla parte del torto, un Paese coloniale, un Paese che ha massacrato e gassato persone e occupato territori; per gli ucraini, la responsabilità - non la colpa - per i propri massacri e pogrom contro le minoranze, i polacchi, gli ebrei.
«Personalmente, papà, preferirei che le persone, invece di sentirsi in colpa per il fascismo di ieri, si assumessero la responsabilità per la democrazia di domani.»
L'assunzione di responsabilità porta alla giustizia, e solo la giustizia conduce alla pace. C'è ancora tempo per farcela, sostiene Melandri, utilizzando la metafora del fuoco che suo padre, durante la marcia forzata verso la salvezza, implorava di accendere per non soccombere al gelo:
«Mio vecchio amico, se non accendiamo subito un fuoco qui, moriremo tutti di freddo..»
«E noi? Riusciremo ad accendere un fuoco in tempo? Non lo so, papà. Ma quando arriverà la tempesta, lo scopriremo.»
“Piedi Freddi” e´ stato pubblicato nella primavera del 2024 in Italia e nell´autunno 2024 nei paesi di lingua tedesca con il titolo “Kalte Füße”. L´edizione inglese e´ prevista per il 2025.




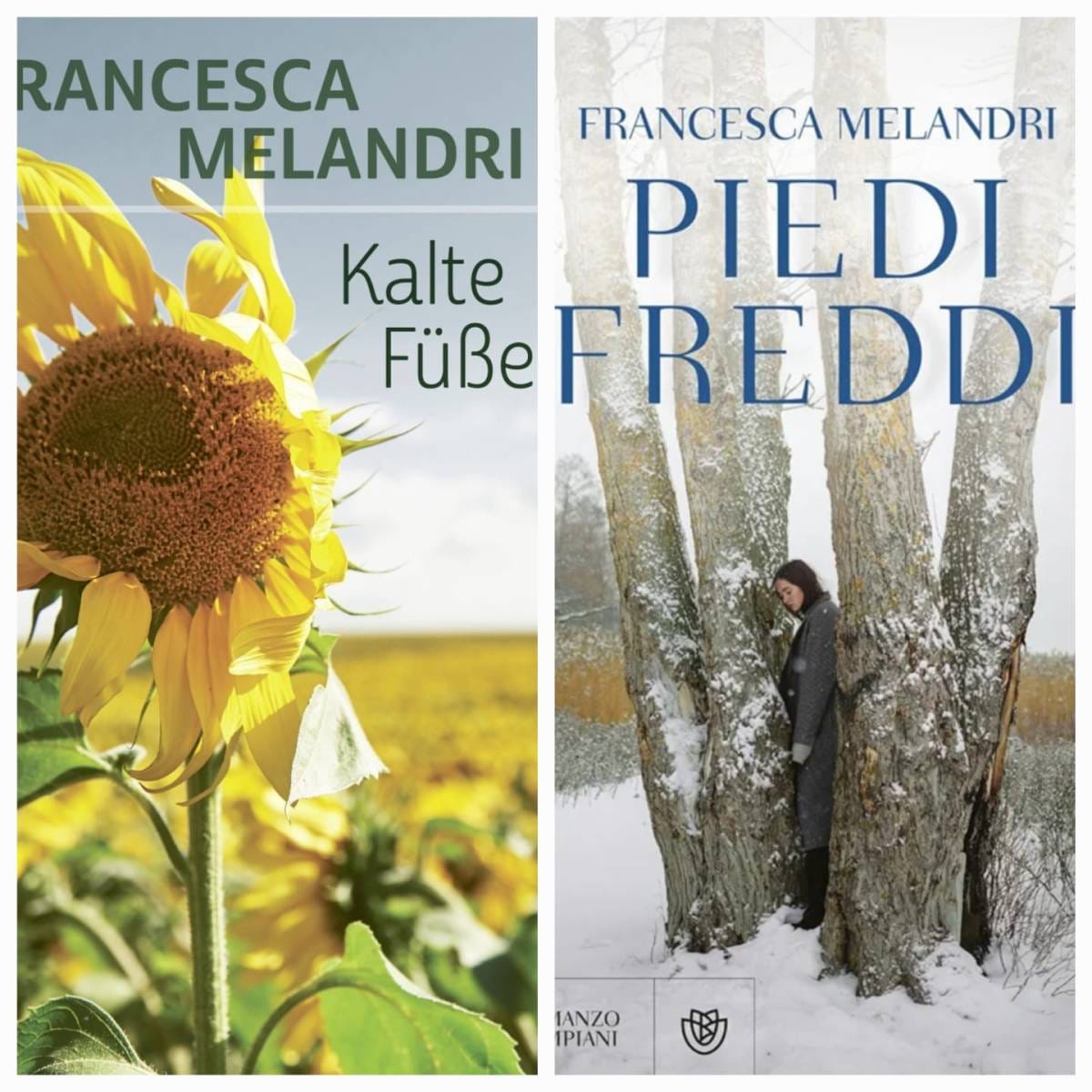





Share this post